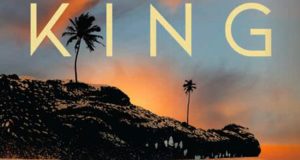Non è un segreto che l’editoria nostrana stia vivendo un momento di grande difficoltà, e i recenti aumenti di prezzo delle storiche testate Bonelli segnano un punto, forse, critico per il fumetto popolare italiano. La riduzione del numero di pagine, il passaggio da mensile a bimestrale o la chiusura definitiva di alcune serie, insieme al proliferare di edizioni variant, sono solo alcuni dei segnali di una crisi sistemica che ha radici profonde. Sebbene i personaggi storici del fumetto continuino a essere acquistati dagli appassionati disposti a spendere oltre 5 euro per albo, le nuove generazioni sembrano meno attratte da Dylan Dog, Tex e simili.
Non è un segreto che l’editoria nostrana stia vivendo un momento di grande difficoltà, e i recenti aumenti di prezzo delle storiche testate Bonelli segnano un punto, forse, critico per il fumetto popolare italiano. La riduzione del numero di pagine, il passaggio da mensile a bimestrale o la chiusura definitiva di alcune serie, insieme al proliferare di edizioni variant, sono solo alcuni dei segnali di una crisi sistemica che ha radici profonde. Sebbene i personaggi storici del fumetto continuino a essere acquistati dagli appassionati disposti a spendere oltre 5 euro per albo, le nuove generazioni sembrano meno attratte da Dylan Dog, Tex e simili.
«Un sacrificio inevitabile quanto ormai indispensabile per poter continuare a produrre i nostri “sogni su carta“», scrive Davide Bonelli a proposito degli aumenti, sottolineando non solo la necessità di adeguarsi ai rincari, ma anche il valore della grande storia editoriale che Bonelli ha saputo costruire nel corso degli anni. La situazione, tuttavia, non riguarda esclusivamente Bonelli, ma coinvolge tutte le realtà che producono e pubblicano fumetti in edicola. Il problema non risiede soltanto negli aumenti dei prezzi, ma nel fatto che tali rincari si inseriscono in un mercato già in difficoltà, rendendo il fumetto popolare sempre meno accessibile. Pur mantenendo un costo competitivo rispetto agli standard internazionali, il vero rischio è che il pubblico generalista si allontani, trasformando il fumetto da prodotto di massa in un bene per pochi.
È fondamentale distinguere tra la crisi economica del settore editoriale e la perdita di identità del fumetto popolare. La prima è determinata da fattori concreti, come l’aumento vertiginoso del costo della carta, che nel luglio del 2022 ha registrato un incremento di prezzo di nove volte rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, la chiusura delle edicole e il calo delle vendite, mentre la seconda riguarda un cambiamento culturale profondo: un tempo simbolo di intrattenimento di largo consumo, il fumetto popolare sembra oggi sempre più destinato a un pubblico di collezionisti e appassionati. Pur intrecciandosi, questi fenomeni sono ben distinti.
Per quanto riguarda la crisi economica, la chiusura delle edicole, il canale tradizionale di distribuzione, ha inciso notevolmente sulle vendite. Dal 2019 il numero di edicole in Italia è diminuito di oltre il 16%, con una riduzione del 21% nella sola provincia di Roma, dove sono state chiuse 303 unità. Questo trend ha reso sempre più complicato per i lettori reperire i fumetti, soprattutto nei piccoli centri. Già nel 2022, diversi editori avevano esortato i lettori a rivolgersi sempre alle stesse edicole per acquistare gli albi, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi dovuti agli invenduti e ai costi di distribuzione. Un appello che, purtroppo, non ha giovato alla situazione, una situazione che richiederebbe una riorganizzazione strutturale da parte dei vertici legislativi e amministrativi, vista la natura ormai obsoleta dei sistemi tradizionali.
 Parallelamente, il fumetto popolare sta perdendo la sua vocazione originaria. Le difficoltà economiche costringono gli editori a contenere i rischi, portandoli a privilegiare formati e contenuti studiati per un pubblico di nicchia, a discapito del vasto mercato delle edicole. Di conseguenza, si assiste al proliferare di riedizioni e di nuove collane destinate esclusivamente alle librerie e ai negozi specializzati, dove i costi di distribuzione sono inferiori. Sebbene questa strategia consenta di rinnovare il materiale, contribuisce anche a snaturare l’essenza del fumetto popolare, che fatica a mantenere la sua identità in un mercato in rapido cambiamento e in luoghi a lui storicamente poco congeniali. L’intrattenimento offerto da smartphone, social media e piattaforme digitali ha ulteriormente accelerato questo spostamento, facendo sì che il fumetto venga percepito sempre meno come un prodotto di largo consumo. Secondo l’Associazione Italiana Editori, nel 2022 i lettori italiani di fumetti erano oltre 10 milioni; tuttavia, nel 2023 le vendite sono calate del 5,3% e nel 2024 il declino ha raggiunto il 5,5%. I lettori sono cambiati e il mercato è diventato più competitivo.
Parallelamente, il fumetto popolare sta perdendo la sua vocazione originaria. Le difficoltà economiche costringono gli editori a contenere i rischi, portandoli a privilegiare formati e contenuti studiati per un pubblico di nicchia, a discapito del vasto mercato delle edicole. Di conseguenza, si assiste al proliferare di riedizioni e di nuove collane destinate esclusivamente alle librerie e ai negozi specializzati, dove i costi di distribuzione sono inferiori. Sebbene questa strategia consenta di rinnovare il materiale, contribuisce anche a snaturare l’essenza del fumetto popolare, che fatica a mantenere la sua identità in un mercato in rapido cambiamento e in luoghi a lui storicamente poco congeniali. L’intrattenimento offerto da smartphone, social media e piattaforme digitali ha ulteriormente accelerato questo spostamento, facendo sì che il fumetto venga percepito sempre meno come un prodotto di largo consumo. Secondo l’Associazione Italiana Editori, nel 2022 i lettori italiani di fumetti erano oltre 10 milioni; tuttavia, nel 2023 le vendite sono calate del 5,3% e nel 2024 il declino ha raggiunto il 5,5%. I lettori sono cambiati e il mercato è diventato più competitivo.
È innegabile che alcuni editori affrontino notevoli difficoltà nella gestione economica, operando in un contesto di regimi fiscali sfavorevoli, costi imprevisti e paradossi sistemici, ed è altrettanto importante riconoscere la loro buona volontà e il loro impegno. Allo stesso tempo però è necessario anche chiedersi se il fumetto popolare sia ancora una forma di arte sostenibile e contemporanea, o se, forse, sia arrivato il momento di ripensarlo per fare in modo che non diventi altro. Ha ancora senso definirlo “popolare” quando ha perso accessibilità, diffusione e, in parte, anche il suo pubblico di riferimento e la sua identità?
Mentre sui social si accendono animati dibattiti sugli aumenti di prezzo, è fondamentale porre critiche costruttive: se da un lato è possibile adottare strategie per affrontare la crisi economica, dall’altro è urgente che editori, lettori e addetti ai lavori si fermino a riflettere sulla direzione che sta prendendo il nostro fumetto popolare e sul futuro che vogliamo riservargli.
–
Simone Fiocco
Bibliografia:
- Associazione Italiana Editori, “Il mercato del fumetto in Italia”, 2022-2024.
- SNAG Nazionale, “Chiusura edicole in Italia dal 2019 a oggi”, 2024.
- Il Sole 24 Ore, “Il calo delle vendite dei fumetti e il mercato editoriale”, 2023.
- Assocarta, “L’aumento dei costi della carta e il suo impatto sull’editoria”, 2024.
- Say Agency, “Perché il costo della carta è aumentato?”, 2022.
- Pricepedia, “Andamento del prezzo della carta e della cellulosa”, 2021-2024.
- Sergio Bonelli Editore, “Aumento di prezzo dei nostri albi”, 2025
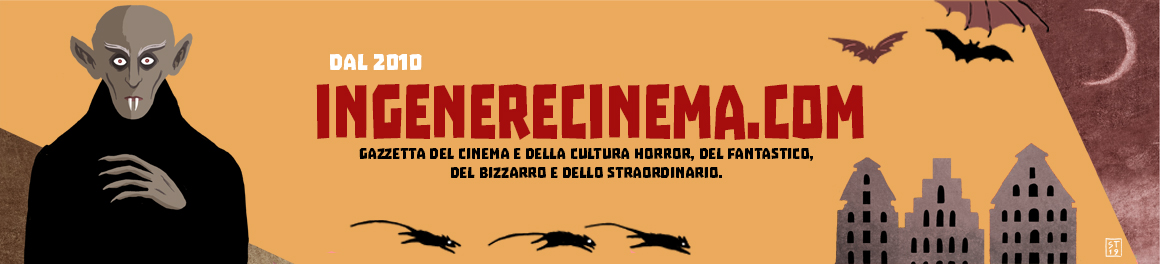 InGenereCinema.com Gazzetta del Cinema e della Cultura Horror, del Fantastico, del Bizzarro e dello Straordinario
InGenereCinema.com Gazzetta del Cinema e della Cultura Horror, del Fantastico, del Bizzarro e dello Straordinario